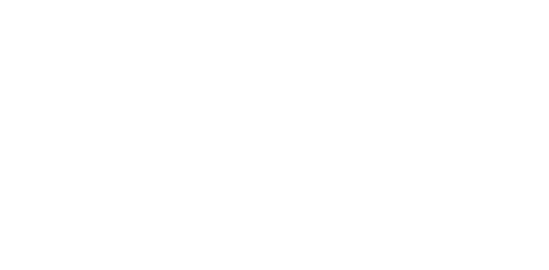Pubblicato in 2020, Le notizie del portale a buon diritto il 22 ott, 2020
Il coraggio di Ilaria Cucchi e il patto Stato-cittadini
Stefano Cucchi nasce il primo ottobre del 1978 e muore il 22 ottobre del 2009 nel reparto detentivo dell’ospedale Sandro Pertini di Roma. Lo scorso 14 novembre, la I Corte di Assise condanna due carabinieri a 12 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per omicidio preterintenzionale a danno del giovane. Attualmente è in corso il processo a carico di otto appartenenti all’Arma dei Carabinieri (tra i quali il generale Alessandro Casarsa) per i reati di falso, favoreggiamento, omessa denuncia, in rapporto a tutte quelle azioni finalizzate a deviare le indagini, occultare le complicità, alterare la relativa documentazione. Nel processo si è costituito parte civile anche il Ministero della Difesa, ma questa apprezzabilissima decisione non attenua - anzi, in qualche modo evidenzia - le responsabilità della rete articolata e autorevole di connivenze e silenzi che, per molti anni, ostacolarono l’attività della magistratura nella ricerca della verità sulla morte del trentunenne geometra romano.
Nell’undicesimo anniversario di quella dolente vicenda, due sono le più importanti lezioni che se ne possono ricavare. La prima. Ilaria Cucchi è una delle molte figure, specie femminili, che accompagnano le tante storie di ingiustizia di cui è fatta la trama degli ultimi decenni della vita nazionale. Dalle “mamme del Leoncavallo”, nate dopo l’assassinio di due giovani del centro sociale milanese, a Felicia Impastato, da Daria Bonfietti, Presidente del Comitato dei familiari delle vittime di Ustica, a Luciana Alpi; e, poi, Haidi Giuliani, Patrizia Moretti Aldrovandi, Lucia Uva, Claudia Budroni, Domenica Ferrulli, fino a Elisa Signori Rocchelli, madre del fotoreporter di Pavia ucciso in Ucraina, e, appunto, la sorella di Stefano Cucchi. E tante altre ancora, spesso anonime e altrettanto spesso dimenticate. Non si tratta, come pigramente si continua a ripetere, di “moderne Antigone”. Nella tragedia di Sofocle, la figura della sorella di Polinice rappresenta - lo dico in estrema sintesi - il conflitto tra le ragioni del cuore e la ragion di Stato, tra il vincolo familiare e quello di comunità, tra la legge del sangue e quella della pòlis. Al contrario, nelle vicende che oggi vedono protagoniste le donne prima citate, è in gioco proprio il principio di legalità, la richiesta alla giustizia di essere giusta, il diritto all’eguaglianza (anche per i poveri cristi, i non garantiti, gli irregolari) di fronte alla legge. In altre parole, quei familiari delle vittime chiedono allo Stato di essere Stato di diritto. E ciò attraverso la rinuncia a una parte del proprio personale lutto per fare di esso una virtù civile e una questione pubblica. Il lutto, al di là della celebrazione dei suoi riti, richiede la massima riservatezza e la più profonda intimità: viene vissuto nella dimensione privata perché è lì che si ritrova l’origine dei legami di sangue che la morte ha spezzato. Dunque, quando la vicenda di ingiustizia che ha troncato una vita raggiunge la sfera dell’opinione pubblica e dell’azione politica, è come se il familiare si privasse di una quota del suo proprio dolore per affidarlo alla collettività. Ed è da qui che muove quel processo di pubblicizzazzione della vittima che, certamente, presenta molti rischi, ma che in tante circostanze è riuscito a imporre verità e giustizia laddove prevalevano menzogna e oblio.
La seconda lezione che si può trarre dalla morte di Stefano Cucchi, e da altre simili, riguarda il rapporto tra il cittadino e lo Stato nella sua nuda essenzialità. La morte del giovane romano, infatti, non può considerarsi alla stregua di una questione umanitaria tra le tante, uno dei non rari episodi di abusi da parte di apparati pubblici, se non addirittura un ordinario caso di malasanità. È ben altra cosa: ed è cosa tutta politica. Con la lunga agonia durata sei giorni e scandita dai successivi passaggi attraverso undici istituzioni pubbliche (caserme, pronto soccorso, camere di sicurezza, infermerie...), si arriva al cuore di un problema cruciale. Come si legge in un qualsiasi manuale di scienza della politica, lo Stato trova la sua legittimazione giuridica e morale nel rapporto di scambio, garantito da un patto vincolante, con i cittadini. Questi ultimi offrono ubbidienza e rispetto delle leggi in cambio della tutela della propria integrità fisica e psichica da parte del potere statuale, nei confronti dei nemici interni ed esterni (criminalità, terrorismo, eserciti stranieri). Se lo Stato non mantiene quella promessa di protezione, è lo stesso fondamento della sua legittimazione a entrare in crisi. E quella promessa di protezione deve estendersi fino alla piena tutela del corpo prigioniero: quando un cittadino si trova nella custodia dello Stato, dei suoi apparati e dei suoi uomini, l’incolumità di quel corpo diventa, per lo Stato, il bene più prezioso. Se così non accade e se lo Stato, lungi dal proteggerlo, attenta all’integrità del corpo prigioniero, è come se crollasse la sua stessa struttura morale. È quanto accade ogni volta che un’istituzione insidia la vita di un cittadino, tanto più quando questi si trovi in una cella, in un presidio sanitario, in un servizio psichiatrico o, comunque, sotto il controllo e alla mercé di un funzionario pubblico. D’altra parte, se rovesciamo il ragionamento, si arriva a comprendere che è proprio la tutela dell’integrità fisica e psichica dell’individuo, contro ogni aggressione e ogni manipolazione, a costituire la base su cui poggia la possibilità di autodeterminazione del singolo. E la sua dignità quale manifestazione del tratto irriducibile e irripetibile della persona. È qui, ancora, che ha il suo fondamento quel “diritto ad avere diritti” di cui ha scritto Hannah Arendt. Ecco, tutto ciò si ritrova nella vicenda di Stefano Cucchi. È per questo che il suo tormentato attraversamento di undici istituzioni dello Stato appare ancora, a distanza di anni, come un doloroso viaggio lungo altrettante stazioni di una infinita Via Crucis.