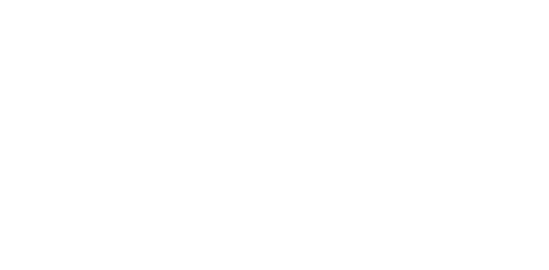Pubblicato in 2017, Le notizie del portale a buon diritto il 18 gen, 2017
Sette anni per accertare l’elementare verità
 Stefano Cucchi. Un tempo infinitamente lungo, intessuto di menzogne e depistaggi per impedire che si guardasse laddove era elementare guardare: al primo impatto tra Cucchi e gli uomini dello Stato, nel momento in cui veniva privato della libertà
Stefano Cucchi. Un tempo infinitamente lungo, intessuto di menzogne e depistaggi per impedire che si guardasse laddove era elementare guardare: al primo impatto tra Cucchi e gli uomini dello Stato, nel momento in cui veniva privato della libertà
Da il manifesto del 18 gennaio 2017
di Luigi Manconi e Valentina Calderone
Quante volte abbiamo scritto e riscritto questo stesso articolo, o qualcosa di assai simile? E, tuttavia, mai come in questa circostanza ciò di cui parliamo rappresenta una vera novità.
Anche le poche note di esile ottimismo che in passato abbiamo potuto registrare non avevano, certo, la forza della prospettiva che oggi finalmente si apre. Ma ciò che conferisce un gusto acido alla fiducia che ora si può nutrire è il fatto che, per rintracciare il bandolo di una matassa tanto aggrovigliata, si è dovuto ripartire esattamente daccapo, a distanza di tanto tempo, spazzando via una rete di infingimenti e inganni, manipolazioni e deformazioni.
E infatti, secondo quanto accertato dalla Procura di Roma, è proprio nel primo atto della tragedia che l’inchiesta troverebbe la sua soluzione. Le violenze che portarono alla morte di Stefano Cucchi sarebbero infatti opera dei tre carabinieri che lo arrestarono nel parco degli Acquedotti, a Roma, la notte del 15 ottobre del 2009.
Dunque, ci sono voluti 7 anni e 3 mesi perché le indagini si concentrassero sulla prima stazione della dolente via crucis del giovane geometra. Un tempo infinitamente lungo, intessuto di menzogne e depistaggi per impedire che si guardasse laddove era elementare guardare: al primo impatto tra Cucchi e gli uomini dello Stato, nel momento in cui veniva privato della libertà.
È allora che comincia a morire, passando attraverso dodici tra luoghi dello Stato e strutture istituzionali (dalla camera di sicurezza di un tribunale al reparto detentivo di un ospedale) senza che una sola delle decine e decine di persone che vi incontra gli presti soccorso, fino al decesso avvenuto il 22 ottobre del 2009.
Ma la violenza che ne causerà la morte avviene proprio nelle prime ore di quella atroce agonia. Perché è stato necessario tanto tempo per accertare questa elementare verità? Tante le ragioni, ma è difficile negare che – come già nella vicenda della morte di Giuseppe Uva, a Varese – le possibili responsabilità di appartenenti all’Arma dei carabinieri inducano gli inquirenti alla massima cautela e a una prudenza che si traduce spesso in omissione.
Questi anni di sicuro non sono passati invano, dato che si sono susseguiti un processo di primo grado, due di appello e infine uno di Cassazione. E anche se diversi per imputati e per esiti, tutti i passaggi hanno avuto un denominatore comune: in nessuno di questi vennero nominati, sentiti e men che meno implicati i tre carabinieri che ieri sono stati rinviati a giudizio per omicidio preterintenzionale dalla Procura di Roma.
Questa è la notizia e, senza voler cantare vittoria in anticipo, è d’obbligo qualche riflessione su quanto potrà ora accadere. Il fatto, cioè, che con ogni probabilità ci sarà un processo, in cui si proverà a dare un’adeguata spiegazione a quelle foto che ritraggono Stefano Cucchi sul tavolo dell’obitorio, scheletrico e gonfio allo stesso tempo, livido e irriconoscibile agli occhi dei suoi stessi familiari.
I processi ai medici e ai dirigenti dell’amministrazione penitenziaria sono stati sicuramente importanti nella ricostruzione di quanto accaduto, ma non hanno risposto alla domanda essenziale: chi ha ridotto così Stefano Cucchi?
Le ipotesi, a ben vedere, non potevano essere molte, considerato che il trentenne romano per più di sei giorni si è trovato nelle mani degli uomini e degli apparati dello Stato. Dunque, da qualche mese sappiamo che nelle indagini iniziali c’è stata un’enorme falla, rappresentata dalla mancata individuazione dei tre carabinieri oggi rinviati a giudizio.
Figure rimaste nascoste, la cui partecipazione alle fasi dell’arresto, della perquisizione e della traduzione in caserma è stata ridimensionata a tal punto da riuscire, per lungo tempo, a renderle invisibili e inafferrabili.
E, da quanto emerge dalle indagini concluse ieri, questa manovra di occultamento non è opera solo dei tre carabinieri interessati, ma anche di colleghi e superiori che pur di proteggerli – in nome di un perverso spirito di corpo – rischiano adesso un processo per calunnia e falso in verbale di arresto.
La vicenda sarebbe potuta finire in modo molto diverso, con dei nomi cancellati col bianchetto e una ennesima morte senza responsabili, ma per una volta non è andata così. Il lavoro della Procura di Roma offre l’ultima occasione di sapere perché – parafrasando Oscar Luigi Scalfaro in occasione di una vicenda simile di ormai trent’anni fa – un cittadino è entrato vivo in un luogo dello Stato e ne è uscito morto.
Il che ci aiuta a evidenziare come a “offendere l’onore dell’Arma” non siano certo quanti chiedono la verità sulla morte di Cucchi, bensì quei carabinieri che, se ne fosse dimostrata la colpevolezza, avrebbero tradito la divisa e il giuramento di fedeltà allo Stato.
E, in ultimo, va ricordato che, se questa atroce vicenda potrà trovare una soluzione, lo si dovrà – in misura preponderante – alla forza di Rita, Giovanni e Ilaria Cucchi, che hanno saputo fare del loro dolore più intimo una risorsa di intelligenza civile.