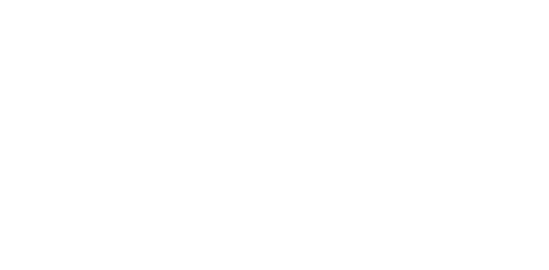Pubblicato in 2016, Le notizie del portale a buon diritto il 17 mag, 2016
Siamo davanti ad un bivio nefasto. Intervista a Luigi Manconi
Magzine , 16-05-2016
, 16-05-2016
Francesco Altavilla, Rita Italiano
Il Senatore Luigi Manconi, presidente dell’associazione A Buon Diritto da anni è impegnato in prima persona nella battaglia di civiltà intorno al reato di tortura. È stato il primo “Garante delle persone private della libertà” presso una amministrazione comunale, a Roma dal gennaio 2004 al giugno 2006. Senatore della Repubblica per due legislature prima di quella in corso, ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario di Stato alla Giustizia nel secondo governo Prodi con delega al sistema penitenziario. È attualmente presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Qual è lo stato dell’arte dell’iter del reato di tortura?
È tutto fermo dopo che la Commissione Giustizia del Senato ha emendato il testo precedente proveniente dalla Camera. A molti è parso un testo peggiorativo rispetto al precedente. La situazione si presenta oggi molto complicata: sarei il primo a chiedere che il testo subisca ulteriori emendamenti, migliorativi questa volta, sapendo però che questo comportebbe il dibattito in aula al Senato, il ritorno alla Camera e così via all’infinito. Siamo davanti a un bivio nefasto: o viene approvato un testo mediocre, assai mediocre, o non viene approvato alcun testo.
Spesso associazioni come Antigone o Amnesty International individuano come punto critico di questo testo il tema delle violenze plurime oltre che psicologiche, oltre alla mancanza di retroattività di questo provvedimento. Secondo lei, in Italia, sarà mai possibile arrivare a un testo che non sia “assai mediocre”?
La risposta è semplice. In questa legislatura, no. Perché la volontà della grande maggioranza, non di Governo ma del Parlamento, è favorevole a un testo men che mediocre. I punti che lei ha evidenziato sono quelli maggiormente critici e difficilmente accettabili. Anche se esiste, va detto, una pressione da parte di molti giuristi critici nei confronti della legge che tuttavia mi rivolgono un pressante invito ad approvarla all’insegna di una parola d’ordine che non va disprezzata ma seriamente valutata: meglio questo di niente. Questa parola d’orodine così dozzinale non va però ignorata.
Nel suo testo originario e anche in quello di Felice Casson (Pd) c’è il riferimento a trattamenti discriminatori.
Il mio testo è totalmente diverso da quello di Casson e ci tengo. Il testo presentato da Casson era favorevole alla tortura come reato comune, il mio definiva la tortura come reato proprio. Il vero scontro iniziale fu su questo punto. La differenza è totale tra tortura come reato proprio degli apparati di pubblica sicurezza o come reato comune. Io sono da sempre favorevole alla definizione della tortura come reato proprio. L’averlo immediatamente ridotto a reato comune ha condizionato in senso molto negativo l’iter legis successivo.
La sua riflessione sul “corpo prigioniero”, presente anche nel suo libro Corpo e anima (Ed. Minimum Fax, 2016), è cominciata negli anni Ottanta con la rivista Antigone. Ci interessava molto mettere a fuoco il discorso della “narratività” che lei individua come modo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questo tema.
Grazie dell’attenzione in profondità. Direi però che la narratività è più un metodo di comunicazione. La sostanza è la mia volontà di partire sempre da un nome e cognome, da una biografia individuale, da una persona in carne e ossa. Ciò riguarda necessariamente un ragionamento sul corpo, oltre che sull’anima. Intendendo per anima la personalità, il carattere, l’elemento psicologico, la sfera delle idee, della creatività, e delle fantasie. Partire da un corpo, cioè da un organismo fisico come oggetto di repressione ma allo stesso tempo sede dei diritti, è di conseguenza posta in gioco per la tutela della dignità della persona. Questo è il fondamento di tutto ed è ciò che mi interessa. Nel fare questo ragionamento utilizzo quella che lei gentilmente chiama la “narratività”: la ritengo una cifra letteraria molto efficace. Però ciò che mi interessa in particolare, per usare categorie classiche, è ricorrere a una metodologia induttiva e non deduttiva. Non partire dalla questione generale, qualunque sia, ma dalle vicende dei singoli. La singola storia che assai rapidamente diventa specchio del tutto.
Sempre all’interno di questo libro si trova cenno a un suo disegno di legge che lei dice sia stato oggetto di poca considerazione da parte dei suoi colleghi: prevedeva per le forze di polizia la formazione alle tecniche della non violenza.
Non ha suscitato solo “scarsa considerazione” ma “grande ilarità”. Un vero caso di ignoranza colta, di trivialità da élite: il ceto giornalistico e il ceto politico. Individui ilari che non sanno che è esistito uno che si chiamava Aldo Capitini. Forse non sanno nemmeno che è esistito uno che si chiamava Mahatma Gandhi. Le tecniche della nonviolenza è il titolo di un libro di Aldo Capitini: cosa volete che ne sappiano? La nonviolenza è un insieme di tecniche e modalità di intervento, anche fisico, che ha come scopo il mettere l’aggressore nelle condizioni di non nuocere o di impedire a qualcuno di farsi aggressore. Stiamo parlando di una complicatissima, raffinatissima tecnica che prevede una cospicua parte fisica che ciascuno di noi amerebbe conoscere. È una modalità di controllo dell’aggressività. Fa ridere perché gli sciocchi sono abituati a pensare che i poliziotti sono delle bestie. Ed è difficile per loro pensare che possano essere non bestie ma esseri umani razionali capaci e preparati.
L’idea di poter operare un distinguo sarebbe nell’interesse stesso della polizia, non crede?
Ma sì. Dirò di più, la mia proposta era sistematica ma un poliziotto medio, mediamente preparato sa cosa sono le tecniche della non violenza. Non è che un poliziotto mediamente preparato impugna sempre una glock e spara. Adotta delle tecniche di contenimento che sono proprie della non violenza. Io ho una certa competenza delle manifestazioni di piazza: i bravi vicequestori che controllano il territorio sanno cosa sono le tecniche della non violenza perché prima di ricorrere alle “mazzate” sfruttano un ampio ventaglio di strumenti dissuasivi pacifici.
E il discorso dei numeri di identificazione sulle divise?
Quello è semplicemente un riflesso reazionario che domina nella stessa identica maniera gran parte dei sindacati di polizia e gran parte della classe politica. Ritengono, del tutto strumentalmente, che consentire l’identificazione dei poliziotti in servizio di ordine pubblico renderebbe possibile rintracciare l’identità degli agenti in servizio e significherebbe esporli ad eventuali rappresaglie. La cosa naturalmente non sta in piedi. È qualcosa di comico, non c’è nulla di serio. Accettare simili provvedimenti sembrerebbe loro una forma di resa, ma non lo è.
Lei crede che nei contesti dei Tso (trattamenti sanitari obbligatori, ndr) e della violenza domestica il reato di tortura potrebbe avere una qualche applicazione?
Sono situazioni molto diverse tra loro. Nulla esclude che il reato di tortura possa essere applicato in altre situazioni. Nel caso di un ospedale psichiatrico c’è un individuo affidato alla custodia di medici e agenti di pubblica sicurezza. Qualora questo affidamento degeneri in un abuso, può configurare effettivamente, a determinate condizioni, il reato di tortura. Altro discorso si deve fare nel caso della violenza domestica. In casi simili si possono chiamare in causa un’infinita varietà di fattispecie penali che potrebbero sanzionare i casi di violenza domestica. La mia impostazione vorrebbe il reato di tortura come reato proprio. Come reato del pubblico ufficiale o di chi esercita funzioni pubbliche: siano il medico di un reparto psichiatrico di diagnosi e cura o un ufficiale di pubblica sicurezza.
Quando nel testo si fa riferimento alle «acute sofferenze fisiche o psichiche», dove si trova l’asticella? Come si fa a determinare se la violenza psicologica c’è stata o no?
L’asticella non può essere quella posta dal testo del Senato che parla di violenze psicologiche plurime clinicamente documentabili. Un esempio che faccio abitualmente è quello della roulette russa. Una pistola puntata contro la tempia che fa fare cinque scatti del tamburo a vuoto costituisce o no una violenza psicologica? Non necessariamente è clinicamente diagnosticabile, documentabile. Per questo esiste il giudice.
Lorenzo Guadagnucci, il giornalista vittima delle violenze alla scuola Diaz individua i fatti del G8 di Genova come uno spartiacque. Sostiene che da quel momento il rapporto fiduciario tra forze dell’ordine e cittadini ha subito un ulteriore deterioramento. Lei condivide quest’analisi?
No, non vedo un legame diretto con i fatti di Genova. Indubitabilmente vedo che dopo Genova è cresciuta la sensibilità collettiva.